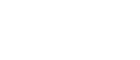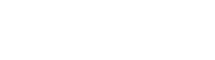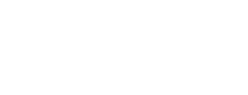Dare uno sguardo alla presenza del Consiglio nazionale delle ricerche all’edizione 2025 di LAB Italia è come avere un assaggio del futuro tecnologico che ci aspetta.
Grazie al contributo organizzativo e progettuale dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr), l’Ente partecipa per il secondo anno consecutivo a LAB Italia, l’evento che mette in relazione il mondo dell’industria con le innovazioni generate dalla ricerca. Sono state selezionate sei tecnologie che saranno oggetto di presentazione in due sessioni dedicate, in programma martedì 17 giugno: qui, ricercatori e ricercatrici, si alterneranno a partire dalle 11.30 con talk della durata di 20 minuti ciascuno.
Sei tecnologie caratterizzate da ambiti applicativi diversi e specifici – tra cui Agroalimentare; Ambiente; Chimico-Farmaceutico e Life Sciences – messe a punto in Istituti di ricerca e laboratori sparsi per tutto il territorio, a testimonianza della varietà di ambiti scientifici e competenze che caratterizza la rete del più grande e importante ente di ricerca del Paese.
Rientra nel settore dei nuovi materiali fotoluminescenti, con applicazioni che spaziano dall’illuminazione alla sicurezza alle tecnologie di screening in ambito biomedico, la tecnologia presentata da Alberto Bossi dell’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” del Cnr di Milano (Cnr-Scitec): con il suo team ha brevettato una classe di materiali che emettono luce nel campo del vicino infrarosso (NIR), e che possono essere integrati in diodi organici a emissione di luce (OLED) per migliorarne le performance ed estenderne l’applicabilità, in particolare in ambito biomedicale.
Antonella Bongiovanni – biologa cellulare in forza all’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Cnr di Palermo (Cnr-Irib) e già presidente di una startup per la produzione di vescicole extracellulari da microalghe – presenta, invece, una piattaforma avanzata per la produzione su larga scala di queste nanoparticelle naturali, che possiedono proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e fotoprotettive tali da renderle “ingredienti” ideali per composti bioterapeutici e formulazioni cosmetiche “green”. Un ulteriore possibile utilizzo riguarda, inoltre, il settore della farmaceutica: opportunamente ingegnerizzate, infatti, tali particelle potrebbero essere impiegate per trasportare farmaci o molecole bioattive, di fatto aprendo la strada a nuove strade per il futuro della medicina.
Sempre in ambito medico si colloca anche la tecnologia presentata da Giorgio Soldani dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa (Cnr-Ifc): sua la messa a punto di un’efficace tecnologia spray per la medicazione di ulcere diabetiche, basata su un composto bioattivo a base di fibrina. Le proprietà coagulanti di tale proteina, unite ad altri fattori, hanno dimostrato eccellenti risultati di riepitelizzazione di ferite ulcerose, oltre a una migliore deposizione del collagene.

Un prodotto dalle molteplici proprietà è presentato anche da Carmela Spagnuolo dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr di Avellino (Cnr-Isa): basato su una innovativa formulazione ottenuta da malti e luppoli, e caratterizzato da un’elevata concentrazione di molecole bioattive, è un candidato ideale per applicazioni in ambito cosmeceutico e nutraceutico come integratore alimentare per uso umano, considerate le sue proprietà antiossidanti e antitumorali.
Venendo, invece, alle tecnologie per applicazione in campo ambientale, Annalisa Natali Murri dell’Istituto di scienza, tecnologia e sostenibilità per lo sviluppo di materiali ceramici del Cnr di Faenza (Cnr-Issmc) illustrerà il processo grazie al quale scarti industriali e residui minerari possono essere trasformati in materiali ad alte prestazioni – caratterizzati da elevate proprietà meccaniche, chimiche e termiche- per usi in campo edile (ad esempio quali leganti alternativi al cemento, blocchi da costruzione, rivestimenti, eccetera), ma non solo: una soluzione, questa, che va nell’ottica della sostenibilità, della chimica verde e dell’eco-design.
Risponde, infine, al problema dell’inquinamento generato da mozziconi di sigaretta l’innovativa metodologia sviluppata da Patrizio Tratzi ed Enrico Facci dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr di Roma (Cnr-Iia): i due sono autori di un brevetto che prevede la separazione dei componenti dei mozziconi – come filtri e residui di tabacco – seguita da un trattamento chimico e fisico che permette di recuperare materiali come l’acetato di cellulosa. Una volta separati, tali materiali potranno essere riutilizzati in vari settori industriali, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti, e offrendo una risposta sostenibile a un problema ambientale diffuso.